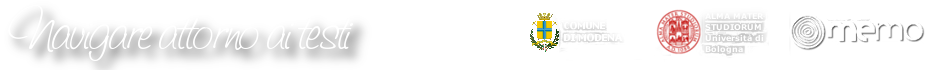5. Non stancarsi di (ri)leggere, anche insieme
I bambini tendono a consumare, letteralmente, i libri, molto più di quanto non facciano gli adulti. Infatti più i piccoli lettori amano osservare, toccare e farsi leggere un testo, e più questo, inevitabilmente, viene consumato dalle manipolazioni, le continue riaperture, i litigi e i tiramolla per accaparrarselo. Il piccolo paradosso, dunque, è che più un libro è consumato fisicamente, più questo significa che esso non si consuma per quello che riguarda la storia che racconta.
I libri e le storie che davvero piacciono ai bambini, infatti, non si consumano mai, come ogni lettore, anche adulto, sa: e la rilettura significa soprattutto rivivere le emozioni già provate e il piacere che questo atto comporta; e anche soddisfare il bisogno di sicurezza che offre ciò che è "noto", cioè la storia che si sviluppa nei particolari, ma senza gli imprevisti del dipanarsi di una fabula sconosciuta.
Ogni insegnante, ma anche ogni genitore, dunque, sa che leggere significa spesso ri leggere, e ascoltare significa spesso ri ascoltare; il primo incontro con una storia che piace è una novità che si guarda con stupore, a volte diffidenza, parsimonia di domande. Ma i successivi incontri con quella stessa storia si tramutano nell'accoglienza all'interno di un universo noto nel quale i piccoli lettori e ascoltatori possono porre domande più liberamente e raccontare particolari; oppure, semplicemente e individualmente, cogliere o sognare nuovi elementi che il testo dice e non dice loro.
Tutto questo è vero, spesso, in due logiche di lettura differenti; quella della lettura individuale e quella della lettura di gruppo, a patto che quest'ultima sia considerata, nella scuola dell'infanzia, il primo passo verso una capacità e un piacere di fruizione condivisa che non deve essere rilegato ai primi anni del percorso d'istruzione.
La scuola dovrebbe tenere sempre in conto infatti che, a qualsiasi età e a qualsiasi altezza curricolare, leggere in gruppo non è solo il modo di rimediare alle inettitudini del giovane lettore che non padroneggia ancora gli strumenti necessari a decifrare, decodificare e comprendere; è invece un universo di condivisione di senso che dovrebbe affiancarsi sempre a quello della lettura individuale.
Eppure gli occidentali, oggi, percepiscono la lettura come un atto perlopiù privato: qualcosa che si fa per se stessi e da soli, sia che si tratti del piacere di una pagina di romanzo, sia che si tratti, più spesso, della necessità di leggere per imparare. E così la pratica condivisa della lettura è delegata al solo apprendistato del libro o, come si è detto, all'attività di recupero.
Invece, come qualche avvenimento mediatico, pur non di frequente, sembra testimoniare, la lettura quando condivisa, regalata e vocalizzata incontra il piacere anche dell'adulto oltre che del bambino. Si tratta non solo del piacere della voce che diventa storia, ma anche del piacere di condividere un'esperienza narrativa, e di confrontare le proprie sensazioni con quelle di altri lettori.
In età scolare è significativa la messa in relazione dei momenti di lettura individuale e di gruppo, tanto più a partire dallo stesso testo. Detto in altri termini, la pratica del laboratorio di lettura non è finalizzata solo alla formazione di buoni lettori singoli, ma anche alla formazione di buoni gruppi di lettori, con una memoria condivisa creata a partire da veri e propri eventi "letturali" vissuti "da un 'noi' che si costituisce intorno al libro e al leggere" 11. In questo ha la massima importanza il coinvolgimento degli adulti (i genitori, per esempio). Come osserva sinteticamente una giovane studiosa, la lettura al nido e alla scuola dell'infanzia "è tanto più proficua quanto più le famiglie ne vengono non solo informate, ma direttamente coinvolte, in modo che i piccoli abbiano la possibilità di viverla in continuità" 12.
Dunque è fondamentale che l'insegnante sappia presentare il momento della lettura in comune come una attività non solo "di passaggio", non solo propedeutica, e, tantomeno, solo scolastica.
6. Le parole e le immagini
La relazione tra il libro e gli altri media si concretizza spesso in un rapporto di esclusione reciproca. Come abbiamo sostenuto altrove 13, la sfida è soprattutto quella di fare incontrare il discorso letterario per l'infanzia con tutto ciò che gli altri mezzi di comunicazione mettono a disposizione. Del resto, già da molti anni si sa che la relazione, ad esempio, tra la pagina e lo schermo può proficuamente diventare un'alleanza, e non una guerra 14.
Su questo occorre fornire due precisazioni fondamentali:
- L'alfabetizzazione iconica è spesso un viatico straordinario per quella linguistica in senso più stretto, in quel contesto complesso che prende il nome di multimodalità; e leggere una storia per immagini non solo è il primo passo della lettura nel contesto prescolare, ma è anche uno strumento di avvicinamento al libro nei casi di necessità di recupero durante la scuola primaria 15, e uno spazio di interazione tra due modi della percezione che accompagna il lettore in tutta la sua vita. Occorre ricordare che nei libri per l'infanzia è praticamente imprescindibile la relazione tra lingua scritta e un altro codice, che è quello iconico; al punto che essi sono classificabili, tra l'altro, proprio in base al rapporto tra quantità di lingua scritta e di immagini. Dunque il testo verbale per l'infanzia ha una modalità di fruizione singolare rispetto agli altri libri: contiene cioè in sé, spesso, anche l'"altro" dell'immagine. La lingua e le immagini richiedono tempi e modi differenti di decodificazione e di interpretazione, ma anche se la lettura verbale e quella visiva non sono sincroniche, com'è stato rilevato, "è proprio dalla loro interazione che nasce quel tipo particolare di comunicazione offerta dall'albo illustrato" 16.
- Bisogna sempre tenere presente l'unicità del testo scritto, e del codice alfabetico, rispetto ad altre forme di narrazione, visiva, sonora e multimediale. Ciò significa, in particolare, che l'angolo di lettura non può e non deve coincidere con gli spazi destinati ad altre fruizioni (televisione, computer, o giochi interattivi), cosicché sia percepita e conservata una specificità e una ritualità della lettura.
11 Cfr. L. Caronia, "Pratiche discorsive e riti comunitari come strumenti di socializzazione: la costruzione del piacere del testo", in I bambini e la lettura. La cultura del libro dall'infanzia all'adolescenza , a cura di V. Gherardi e M. Manini, Carocci, Roma, 1999, pp. 167sgg.
12 E. Freschi, Le letture dei piccoli. Una proposta di "categorizzazione" dei libri per i bambini da 0 a 6 anni , Edizioni del Cerro, Pisa, 2008, p. 33.
13 Y. Martari, "Per una semiotica della letteratura infantile", in Poetiche , 1/2011.
14 Cfr. per esempio, L. Caronia, V. Gherardi, La pagina e lo schermo. Libro e TV: antagonisti o alleati? , La nuova Italia, Scandicci, 1991.
15 R. Cardarello, "Guardare le figure per leggere una storia", in Leggere prima di leggere. Infanzia e cultura scritta , a cura di R. Cardarello e A. Chiantera, cit
16 E. Freschi, Le letture dei piccoli. Una proposta di "categorizzazione" dei libri per i bambini da 0 a 6 anni , cit., p. 91.
© 2015. MEMO "Multicentro Educativo Modena S. Neri"
Viale Jacopo Barozzi, 172. 41124 Modena. Italia.
È vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo analogico o digitale
senza il consenso scritto dell'editore.
Per informazioni scrivere a: memo@comune.modena.it