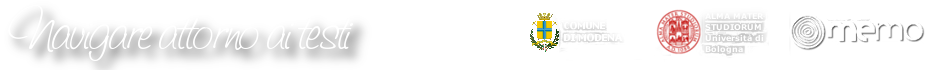3. Interpretazione e conoscenza
Il problema dell'interpretazione discende, in filosofia, da quello, più generale, della verità: che cosa è vero? Che cosa è oggettivo?
Si tratta, nella cultura contemporanea, del punto centrale della ricerca epistemologica (ovvero la filosofia della conoscenza): «definire l'oggettività (o meno) della conoscenza oggettiva».
I presupposti di Fish sono infatti speculari a quelli di Thomas Kuhn (e di altri epistemologi: Edgar Morin, Magaroh Maruyama ecc) quando affronta la questione del paradigma . Un paradigma, in senso scientifico e culturale, è molte cose: più di tutte un sovrano sotterraneo che modella la conoscenza , che informa la logica e detta criteri di ammissibilità a ciò che si dice e può essere detto, ma anche di ciò che si vede e di ciò può essere visto. In altre parole, un paradigma è ciò che costituisce il parametro delle nostre verità più indubitabili. Ad esempio, la maggior parte di noi crede che si possano vedere gli atomi senza averne mai visto uno. E questo, dice Kuhn, perché abbiamo fede in una società scientifica e nella sua oggettività. E in questo non c'è nulla di male, purché siamo consapevoli che tale oggettività è mutevole.
Insomma esiste, per Kuhn, una scienza normale (che è il contrappunto della nostra interpretazione normale), che aderisce al paradigma all'interno della quale si sviluppa, ed esiste quindi una teoria standard che corrisponde al modo istituzionalmente corretto di vedere e significare le cose del mondo.
Come a dire che gli oggetti non sono poi così oggettivi, perché anch'essi mutano col mutare del paradigma, insieme alla teoria standard, insieme cioè alle idee degli uomini su ciò che è normale e su ciò che non lo è.
Occorre a questo punto abbozzare rapidamente un quadro più esteso all'interno del quale inserire la visione kuhniana. Tale quadro sarà utile, come vedremo, anche per la nostra discussione sul problema dell'interpretazione.
Esistono, approssimando le correnti critiche dell'epistemologia contemporanea, quattro indirizzi forti e nitidamente riconoscibili, che ora elenchiamo in modo estremamente sintetico, invitando il lettore a considerarne la portata anche per ciò che concerne la verità interpretativa del testo:
3. 1. Una posizione realista forte
Per essa la realtà, che esiste oggettivamente, e la teoria - e quindi l'umana comprensione - si trovano sempre in contatto, pur attraverso varie approssimazioni. È per esempio la posizione di Hempel il quale sostiene che la teoria sia una sorta di rete sospesa nello spazio ma in stretta comunicazione con il piano della realtà sul quale ci muoviamo. Questa comunicazione avviene grazie a dei «fili di giunzione»: tali fili rappresentano le interpretazioni. Il che è come dire che l'interpretazione lega la conoscenza e la realtà oggettive.
Potremmo parafrasare questa posizione dicendo che esiste sempre un'interpretazione giusta, così dei fenomeni, come di un testo, letterario o giuridico. La lettura corrisponderebbe quindi a esiti oggettivamente giusti o sbagliati.
3.2. Una posizione realista debole
Al realismo forte che qualcuno ha anche definito «tesi della stabilità» si contrappone un fronte un po' più critico dove troviamo ad esempio Hilary Putnam, un realista «debole» che sostiene la perenne possibilità di devianza e permutabilità della teoria, rispetto a una realtà comunque data. Un esempio chiarisce la posizione di Putnam: «per quanto possa cambiare la nostra teoria della carica elettrica, c'è un elemento nel significato del termine "carica elettrica"che per il realista non è cambiato negli ultimi due secoli: il riferimento. "Carica elettrica" si riferisce alla stessa grandezza, anche se la nostra teoria di quella grandezza è radicalmente cambiata».
In questo caso, per ciò che riguarda l'ambito interpretativo, esisterebbero interpretazioni apparentemente giuste o sbagliate, ma rispetto a una verità interpretativa comunque data. Come a dire che gli esseri umani (e quindi i lettori) sono sempre passibili di errore, ma da qualche parte la verità del testo c'è, e non è mutevole.
3.3. Una posizione relativista debole
La realtà degli oggetti dati è invece esclusa dalla posizione di Thomas Kuhn per il quale ogni teoria, oltre ad avere delle idee proprie, ha anche degli oggetti propri: non solo le interpretazioni ma anche i fatti cambiano. E così, per esempio, la categoria fisica «massa» cambia a seconda delle teorie (e dei paradigmi), insieme alle interpretazioni che della categoria si danno, e lo stesso dicasi per la categoria ossigeno: «Lavoisier vide l'ossigeno laddove Priestley vide aria deflogistizzata e dove altri osservatori non avevano visto assolutamente nulla» . E tutte le nostre percezioni del mondo sono dunque - non di meno - profondamente legate a ciò che con Fish (che appartiene a questa corrente) abbiamo definito normalità e situazionalità, al punto che persino le impressioni retiniche degli occhi degli scienziati sono influenzate e determinate da ciò che essi sanno e da ciò che essi si aspettano dalla loro osservazione.
Secondo questa posizione, un'interpretazione è giusta o sbagliata solo in relazione a un contesto culturale e sociale che influenza e determina il concetto stesso di verità, anche per ciò che concerne un testo letterario o un fenomeno linguistico.
3.4. Una posizione relativista radicale
Il gradino successivo, l'ultimo, è occupato dall'anarchico metodologico che, come Paul Feyerabend, si pone più che altro come «un agente segreto che giochi la partita della Ragione allo scopo di minare l'autorità della Ragione (della Verità, dell'Onestà, della Giustizia ecc)» . L'accusa mossa dall'anarchismo è che le teorie - tutte le teorie - diventino «ragionevoli» soltanto dopo che tutte le incoerenze, e tutte le cose che le teorie non possono spiegare vengono dimenticate e fatte dimenticare. Senza anarchismo, dice Feyerabend, non esiste progresso (in qualsiasi connotato si voglia prendere tale termine). Perciò, al di là di ogni comunicabilità teorica, «c'è un solo principio che possa essere difeso in tutte le circostanze e in tutte le fasi dello sviluppo umano. È il principio: qualsiasi cosa può andare bene»3 . Tale anarchismo finisce però col sembrare spesso più autarchico e più rigido della Ragione cui si oppone, conducendo a effetti (per altro volutamente) paradossali.
Secondo questa posizione, ogni atto interpretativo riguarda soltanto il soggetto, il lettore, e non è né aderente a qualsivoglia verità testuale, né in qualche modo comunicabile all'esterno, dunque non è neppure condivisibile.
3 Cfr. P.K. Feyerabend, tr. It. Contro il metodo: abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza , Milano, Feltrinelli, 2008.
© 2015. MEMO "Multicentro Educativo Modena S. Neri"
Viale Jacopo Barozzi, 172. 41124 Modena. Italia.
È vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo analogico o digitale
senza il consenso scritto dell'editore.
Per informazioni scrivere a: memo@comune.modena.it