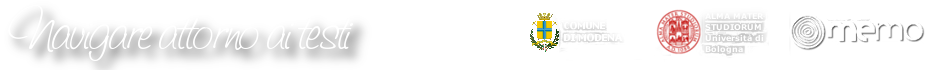5. Una lezione (di scrittura) di Dino Buzzati.
Lettura significa immersione, suggestione, attenzione.
A questo punto proviamo a leggere un testo e ad avventurarci in un'interpretazione, riflettendo soprattutto su quale sia il rapporto tra parte e tutto, parola e complessità del testo conchiuso, in modo meno speculativo. Immergiamoci, per quanto lo spazio di un'esemplificazione lo consenta, in un testo: proviamo con l'incipit di uno dei classici della recente letteratura italiana.
Nominato ufficiale, Giovanni Drogo partì una mattina di settembre dalla città per raggiungere la Fortezza Bastiani , sua prima destinazione.
Si fece svegliare ch'era ancora notte e vestì per la prima volta la divisa di tenente. Come ebbe finito, al lume di una lampada a petrolio si guardò nello specchio, ma senza trovare la letizia che aveva sperato. Nella casa c'era un grande silenzio, si udivano solo piccoli rumori da una stanza vicina; sua mamma stava alzandosi per salutarlo.12
Concentriamoci unicamente sul problema del rapporto tra parola e testo, anche se l'analisi di questo passo si presterebbe a molte analisi e considerazioni.
Il primo periodo è uno dei famosi incipit di Buzzati, in cui il quadro della vicenda viene abbozzato in poche parole, essenzialmente, in modo quasi lapidario. Una piccola parte, poco più di due righe, contiene tutta la storia. Per chi conosce questo romanzo sarà un'ovvietà, ma forse è comunque il caso di ricordare che nel Deserto dei tartari non accade nulla che non sia già contenuto in questo periodo. Un uomo parte da una città non meglio specificata e prende servizio come ufficiale in una fortezza. Il romanzo si brucerà, poi, come la vita di quell'uomo, Giovanni Drogo, nell'attesa di un avvenimento che non accadrà mai.
Consideriamo il secondo periodo. "Si fece svegliare ch'era ancora notte" può essere un primo elemento su cui soffermarsi. Andiamo senza indugio al di là dell'informazione temporale e cerchiamo di indagare su cosa voglia significare questa notte. Il dialogo inizia e, in un caso come questo, è un dialogo immediato, quasi scontato. Il testo ci chiede di pensare alla notte, innanzitutto. Non si fece, Drogo, svegliare alle prime luci dell'alba, con un sole nascente a illuminare tutta la nuova vita del protagonista oltre che la narrazione. È notte quando il giovane ufficiale si alza. E sarà notte lungo tutto il romanzo, se alla notte diamo un valore di attesa, di sosta, ma anche di oscurità, come accade essa abbia nella nostra cultura. Forse, potremmo intravedervi anche un pizzico di paura dell'ignoto. Ma, comunque vogliamo rispondere all'invito di questa "notte", Drogo che si veste davanti allo specchio mentre tutto il mondo dorme, è un'immagine tutt'altro che radiosa.
Ecco la prima risposta del lettore, dunque, rivolta alla prima domanda che il testo porge. Parafrasiamo l'invito del testo: "sai pensare la notte, lettore? Cosa accade nella tua mente quando leggi la parola "notte"?" Dalla nostra capacità di rispondere a tale invito scaturisce il dialogo ermeneutico: le singole domande sui vari elementi testuali, sulle singole "parti" del testo, divengono presto una trama dialogica che illumina la totalità del tessuto testuale.
Proseguiamo il nostro dialogo e leggiamo oltre: "al lume di una lampada a petrolio" ci fa venire in mente immediatamente qualche cosa di flebile e un po' cupo. Esattamente come flebile e cupa è tutta la storia raccontata per duecento pagine. L'immagine di Drogo si fa sempre più grigia, dipinta a tinte incerte, nel buio della notte, nel lume di una lampada a petrolio. Forse solo la parola petrolio, solo quella, basterebbe, con la sua pesantezza, a vanificare quel barlume di luce. Poche parole hanno in sé, se sappiamo coglierle e sappiamo rispondere all'invito che ci viene fatto di costruire senso insieme al testo, tutto quello che il romanzo ci porterà a scoprire.
"Si guardò nello specchio, ma senza trovare la letizia che aveva sperato." È uno strano, triste mattino, quello del nostro ufficiale. È un mattino che inizia quando è notte, è un mattino in cui guardandosi allo specchio scopre che non esiste la felicità che aveva pensato; come non esiste quello che per tutta la vita, invano, aspetterà. Per tutta la vita e, diciamolo ancora una volta, per tutto il romanzo.
Prendiamo in considerazione ancora l'espressione "nella casa c'era un grande silenzio", oppure riflettiamo sui "piccoli rumori" che, soli, si odono in questo mattino di Drogo. Muovendoci sul terreno dell'analogia, potrebbe venirci in mente l'ovatta, l'attutirsi di ogni rumore - di ogni avvenimento, per quanto riguarda il romanzo - e l'imperversare di un silenzio rotto solo da rumori di poco conto, come di poco conto è tutto quello che succede in questa, in fondo silenziosa, storia.
Prima di tentare ancora un passo su questa via, fermiamoci a fare qualche considerazione su quanto abbiamo provato a leggere: ci stiamo davvero muovendo all'interno del circolo ermeneutico, tra parola e testo, tra parte e tutto. Abbiamo preso alcune, pochissime, parole e vi abbiamo trovato il senso profondo di tutto il testo. Un senso che è la vera lettura.
E tentiamo quindi di fare ancora un passo su questo terreno. Proviamo a comprendere perché questa notte, che contiene ed è contenuta da tutto il romanzo, immediatamente potrebbe dare un'immagine di sé così cupa e dolorosa. Facciamo delle ipotesi, senza timore. La notte descritta potrebbe sapere d'inverno, per esempio, di freddo13. Oppure si potrebbe riflettere sull'illusorietà di un mattino che non è mattino, ma è notte. O, ancora, si potrebbe fare appello alle esperienze e ai ricordi della nostra vita trascorsa, che ci portano a considerare la notte sotto un determinato aspetto. Quali risvegli bui significa per noi il sintagma "svegliarsi ch'è ancora notte"? Riflettere intorno a queste semplici, e del tutto intuitive, questioni, significa già cominciare a scoprire quanto profondamente il lettore è chiamato a mettere in gioco la sua esperienza in ogni percorso ermeneutico.
12 Buzzati D. Il deserto dei tartari, Mondadori, Milano, 1998, p. 3.
13 Nel Deserto dei tartari il freddo è mortale. Basti pensare all'episodio di Angustina, soldato ucciso dall'inverno, al termine di una lotta, impari, con se stesso e con l'addiaccio.
© 2015. MEMO "Multicentro Educativo Modena S. Neri"
Viale Jacopo Barozzi, 172. 41124 Modena. Italia.
È vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo analogico o digitale
senza il consenso scritto dell'editore.
Per informazioni scrivere a: memo@comune.modena.it