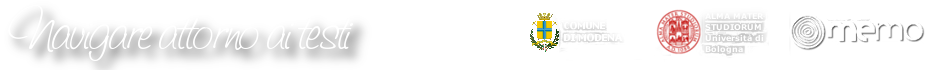2. Una lezione di Italo Calvino.
La lettura è una pratica a due facce: l'emozione e l'analisi.
Per insistere sul parallelo tra complessità e lettura, sarebbero di certo ugualmente validi molti punti di avvio, perciò dovremo muoverci un po' audacemente, cercando di argomentare qualcosa che un'affermazione di Flannery O'Connor riassume perfettamente: nella lettura, diceva, "si analizza per gustare, ma è altrettanto vero che per analizzare con un minimo di discernimento occorre aver già gustato"3. Leggere è coinvolgimento ingenuo da un lato, dunque, e sguardo analitico dall'altro, come sempre coinvolti in una relazione simmetrica, retroattiva, di reciproca generazione: dal piacere al vedere e dal vedere al piacere.
Ma proviamo a dire tutto questo seguendo un'altra voce, tra le pagine di un romanzo - spesso molto amato dagli studenti e assai discusso dai critici - che di nient'altro parla che non sia la lettura: Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino.
La letteratura, prima di tutto, è sempre un atto verginale, una pratica d'incertezza e di imprevedibilità: leggere senza svelare nulla del meccanismo linguistico e retorico che sottende all'incanto che il testo fa scaturire in noi. Il desiderio, cosciente, di non "svelare il trucco"; proprio come la protagonista femminile di Se una notte d'inverno un viaggiatore.
Ludmilla, così si chiama questa Lettrice con la L maiuscola, è coscientemente preda della meraviglia e non vuole per nessuna ragione valicare il muro che separa chi crea il libro da chi lo legge. Alla sua voce concediamo una breve citazione: "c'è una linea di confine: da una parte ci sono quelli che fanno i libri, dall'altra quelli che li leggono. Io voglio restare una di quelli che li leggono, perciò sto attenta a tenermi sempre al di qua di quella linea. Se no, il piacere disinteressato di leggere finisce, o comunque si trasforma in un'altra cosa, che non è quello che voglio io"4. Questo qualcosa è ciò che ogni lettore conosce: il piacere di essere trascinati via dalla voce del testo, dalle sue parole, senza mai vedere cosa c'è dietro la pagina, qual è l'intreccio di dispositivi che crea la meraviglia.
Al di là della caratterizzazione della nostra Ludmilla, è certo che senza meraviglia non si legge, se non per dovere; non c'è coinvolgimento, né quella scoperta, riflessa, di sé che garantisce al lettore di creare senso insieme al testo.
Solo secondariamente avviene il passaggio all'analisi della complessità del dettato testuale. Ciò che prima era solo un soffio, indistinto e affascinante, ora diventa una trama di fili intrecciati, un reticolo di sentieri che il lettore deve scegliere, seguire, abbandonare, rincontrare. Proprio in questo reticolo scopriamo che una lettura complessa non può non essere ipertestuale , cioè in grado di richiamare elementi che vanno oltre il testo verso altri testi e verso una pluralità di livelli di analisi ; il che significa considerare ogni parola e ogni lessema, a livello semantico, e ogni fonema a livello linguistico, contenuti in un testo, dei possibili link attraverso cui accedere a un universo infinito di informazioni, in cui tracciare infiniti percorsi di lettura. Non si tratta di un viaggio senza meta nei territori, sempre incogniti, dello scibile, né di pura erudizione; pensiamo piuttosto a ciò che George Steiner definisce "lettore filologo"5, cioè il lettore accorto e cortese nei confronti del proprio testo, che vive l'incontro con la lettura come un atto di ospitalità, accogliendo prima il lessico, poi la sintassi del testo e, ancora una volta, scommettendo sulla possibilità di riuscire a significarlo. Il testo diventa ipertesto proprio nell'inseguire quei sentieri sintattici e semantici che rivelano il vero cuore della filologia: l'amore della parola, che protegge il nucleo di senso e anche di incertezza che ogni testo custodisce.
Continuando a seguire il romanzo di Calvino, possiamo forse pensare al "professo Uzzi Tuzii" di cui ci viene detto: "quando ti sei convinto che al professore la filologia e l'erudizione stanno più a cuore di tutto ciò che la storia racconta, ti accorgi che è vero il contrario: quell'involucro accademico serve solo per proteggere quello che il racconto dice e non dice, un suo afflato interiore sempre lì lì per disperdersi al contatto con l'aria, l'eco d'un sapere scomparso che si rivela nella penombra e nelle allusioni sottaciute"6. Nelle penombre, nei luoghi d'oscurità e di rarefazione del significato: lì dimora il senso, protetto dalla costruzione retorica che il lettore deve accogliere su di sé, per accedere e ritornare alla meraviglia.
La lettura è sempre un itinerario di complessità: un passaggio dalla prima fascinazione alla teoria cortese della lingua, che ha come esito il ritorno all'incanto della parola. Un passaggio attraverso la riflessione, la filologia e l'ermeneutica, che dal primo senso sottile, quello dell'incontro, conduce a un senso più forte, quello dell'accoglienza e dell'amore per il testo conosciuto e dialogato.
Due modi di leggere, dunque, di cui troviamo un'immagine nitida nelle pagine di Calvino. E riflettere sulla didattica della lettura significa anche provare a comprendere come i due modi si incontrino in una sola anima per il lettore esperto e consapevole. Ma prima di tutto la caratterizzazione di due poli opposti dei modi del lettore ci serve per interrogare noi stessi e i nostri studenti sull'immagine cui ci sentiamo più vicini. "Chi siamo?", ci interroghiamo per gioco, come in un test, "Siamo più Ludmilla o più Uzzi Tuzzi? Di che natura è il nostro dialogo col testo?"
3 O'Connor F. Nel territorio del diavolo. Sul mistero di scrivere, Minimum Fax, Roma, 2003.
4 Calvino I. Se una notte d'inverno un viaggiatore , Einaudi, Torino, 1979, pp. 106-07.
5 Cfr Steiner G. Vere presenze, Garzanti, Milano, 1999.
6 Calvino I. Se una notte d'inverno un viaggiatore , op. cit. p. 79.
© 2015. MEMO "Multicentro Educativo Modena S. Neri"
Viale Jacopo Barozzi, 172. 41124 Modena. Italia.
È vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo analogico o digitale
senza il consenso scritto dell'editore.
Per informazioni scrivere a: memo@comune.modena.it